[altro] stato dell’amante furioso, celebrato nel sonetto successivo, lo vede in una condizione dilaniante, espressa in modo mirabile dal verso…
in viva morte morta vita vivo.
È la condizione di Issione, re tessalo dei Lapiti, il primo assassino secondo la mitologia greca (in qualche modo omologo del biblico Caino), che uccide suo suocero Deioneo pur di non assolvere al suo dovere di versare la dovuta dote in seguito al matrimonio con la figlia di costui, Dia. Perdonato da Zues, Issione dimostrò la sua scelleratezza tentando di sedurne la moglie, Era. Il padre degli dei lo ingannò facendolo accoppiare con una nuvola a cui aveva dato le sembianze di Era ma, quando da quella unione innaturale nacque Centauro (o, secondo alcuni, i centauri), lo dannò a restare per l’eternità negli inferi, legato ad una ruota infuocata che girava senza sosta, frustato da serpenti.
Tale condizione sentenzia Bruno è doppio vizio poiché non tende verso il mezzo tra i due estremi, pur trovandosi costantemente nel mezzo, giacché la sua aspirazione è verso uno qualsiasi dei due estremi.
“Non è morto, perché vive ne l’oggetto; non è vivo, perché è morto in se stesso; privo di morte, perché parturisce pensieri in quello; privo di vita, perché non vegeta o sente in se medesimo.” Spiega Tansillo/Bruno; e, riferendosi alla posizione assunta da Issione sulla ruota aggiunge, a completamento della condizione deprecabile del furioso che cade in tale stato: “Appresso, è bassissimo per la considerazion de l’alto intelligibile e la compresa imbecillità della potenza. E` altissimo per l’aspirazione dell’eroico desio che trapassa di gran lunga gli suoi termini; ed è altissimo per l’appetito intellettuale, che non ha modo e fine di gionger numero a numero; è bassissimo per la violenza fattagli dal contrario sensuale che verso l’inferno impiomba. Onde trovandosi talmente poggiar e descendere, sente ne l’alma il più gran dissidio che sentir si possa; e confuso rimane per la ribellion del senso, che lo sprona là d’onde la raggion l’affrena, e per il contrario.”
In sostanza, Bruno ammonisce a non aspirare a traguardi che trascendono le proprie forze, pena il perdere non solo l’obiettivo ma anche la corretta percezione di sé: ecco il doppio vizio a cui si era riferito.
Ma tale è, molto spesso, la condizione di chi ama non riamato. E il tributo che l’uomo paga è spesso la follia, quella che porta Pastore (la figura citata in un riportato dialogo con il saggio Filenio) a dire: “Temo il suo sdegno, più che miei tormenti.”
Non vede, il folle, la sua pazzia? Certo che sì, dice Bruno; eppure, è pronto a ribadire:
Mai fia che dell’amor io mi lamente,
senza del qual non vogli’esser felice.[1]
[1] Sono i primi due versi del quarto sonetto del quinto dialogo – I parte.

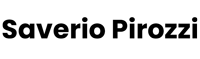
Lascia un commento